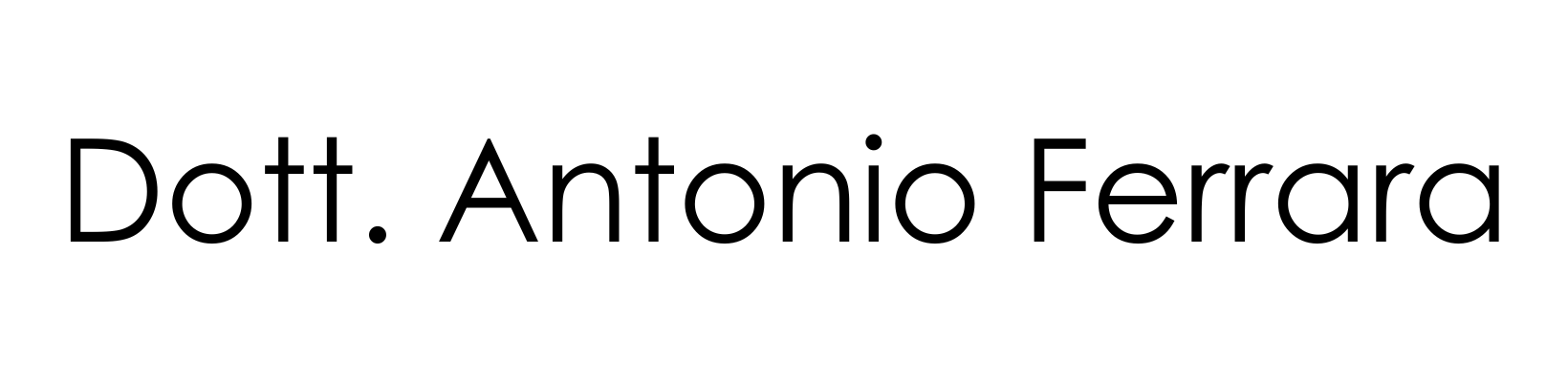“Al di là dell’immagine: puoi essere come sei”.
Conosco poco la paziente, con la quale non ho avuto precedenti contatti terapeutici. Tuttavia so che appartiene alla tipologia numero tre secondo la psicologia degli enneatipi, la caratterologia fondata sull’enneagramma. Una persona “vanitosa”, che tende a ingannarsi a causa di fissazioni cognitive attraverso le quali attribuisce un particolare valore alla propria immagine.
Incomincia a parlare molto agitata e racconta che da alcuni giorni vive un forte disagio. Si rende conto, come mai prima, di essere ossessivamente attenta gli sguardi delle persone. Non appena ne incrocia una cambia atteggiamento, si mette in posa. Cerca l’espressione, la postura che la renderà più interessante e l’assume adattandosi. Se nel posto dove si trova non ritiene di essere particolarmente visibile, lentamente, senza dare nell’occhio, si muove, si sposta, fingendo indifferenza o inventandosi qualcosa da fare, finché non sente di essere in ‘primo piano’. Nonostante se ne renda conto e provi un forte disagio, il suo comportamento è irrefrenabile. Vorrebbe scappare e isolarsi per evitare qualsiasi contatto e porre fine a questa tortura. Effettivamente il racconto risulta angosciante. Inoltre le è accaduta una cosa strana, continua a dire con un misto di rabbia e impotenza. Le si è avvicinato un compagno di gruppo commentando: “Bello ieri sera, vero?”. Parlava di un posto dove lei non era stata. “Ma io non c’ero”, ha risposto. “Come no”, dice l’altro, “ti ho anche parlato”. Dopo un poco un’altra persona aveva ripetuto una scena simile. “Sembra una provocazione, mi vedono anche dove non ci sono. Mi sento ridicola ora. Sicuramente è un messaggio. Chi me lo manda?”. In effetti queste persone avevano agito attuando un compito terapeutico rivolto a provocare una sua reazione. Con la prima aveva avuto il dubbio di essere ‘fuori di testa’, ma dopo il secondo incontro aveva sentito angoscia. “Questo non è casuale… cosa vogliono dirmi?”, si chiede.
Che cosa sta vivendo? Che cosa accade? Il suo discorso è piuttosto confuso e io stesso mi sento invaso da un fiume di parole accompagnate da una voce lamentosa e da tante pause e interruzioni. Non c’è più la persona capace è sicura che avevo incontrato nei giorni precedenti. Il primo passo ora, è quello di individuare il problema e che cosa mi chiede. Tendo alla focalizzazione che mi permette di seguire una direzione chiara e mi do come obiettivo un lavoro ‘puntuale’, visto il tipo di setting, che non prevede un rapporto prolungato nel tempo. Decido di applicare una tecnica che deriva dall’analisi transazionale ma con modalità gestaltica: la tecnica delle tre sedie. La trovo particolarmente utile per gli stati di confusione. Aiuta a separare le parti della personalità e a individuare i messaggi conflittuali che attivano il dialogo interno. Le spiego la modalità di lavoro e sulla terza sedia, quella in più rispetto al tradizionale modello di statico, metto la parte osservante della personalità, l’Adulto capace e razionale, in grado di valutare dati e attribuire significato, ma anche capace di operare scelte consapevoli. Sulle altre due sedie si alternano le parti in conflitto. Inizio interrogandola mentre sta sulla sedia nella quale le chiedo di identificarsi in lei bambina. Nei momenti di forte disagio sono gli stati arcaici della personalità quelli più attivi. Tuttavia l’indicazione è metaforica, perché non le chiedo di regredire attivando un ricordo storico, ma la mantengo presente nel qui e ora.
Terapeuta: Che cosa stai vivendo oggi, a causa dei fatti che racconti?
Paziente: Mi sento confusa… angosciata… Mi sento come in trappola… Non so che fare.
Terapeuta: E che cosa ti stanno dicendo queste persone? Dillo intuitivamente, senza pensare.
(Il bambino si esprime con meno difese e al di là del ragionamento, attraverso una intuizione spontanea. È più facilmente in contatto con il vero senso delle esperienze che vive, adopera meno filtri.)
Paziente: Mi stanno dicendo che rompo le palle… che sto da tutte le parti… che rompo le palle…Ma io non voglio essere così.
(Parla con voce infantile e angosciata. C’è una parte di lei alla quale non piace il proprio comportamento. Emerge dal suo: “ Ma io non voglio essere così”. Le chiedo di spostarsi su un’altra sedia ed identificarsi con quella parte di sé che disapprova. Così può esplicitare il dialogo interno che, in maniera ancora inconsapevole, la tortura. La prima catarsi avviene portando fuori quanto vive represso sullo sfondo. Non le do particolari indicazioni su come farlo. Sto saggiando le risposte. Mi sento ancora incerto con lei e ho bisogno di orientarmi per mettermi in sintonia con le sue richieste effettive, per poi stabilire la relazione).
Paziente: ( Sbotta con tono forte, energico) Hanno ragione a fare così… Perché rompi, stattene un po’ tranquilla, invece devi stare dappertutto. Quello che stanno dicendo è che stai dappertutto e così dai fastidio, rompi le palle… ( Parla alla bambina che le sta di fronte con il tono di un genitore insofferente. La invito a spostarsi sulla sedia dell’Adulto consapevole). È chiaro che vogliono dirmi che rompo con questa mia attitudine a voler stare in ogni posto. (Ora si esprime sicura. Incomincia a contattare qualcosa di concreto, anche se in effetti non può sapere cosa realmente pensino gli altri. Decido comunque di proseguire verso l’obiettivo che mi sono proposto).
Terapeuta: (Parlando ancora all’Adulta) Cosa vuoi ottenere da questa seduta? (Cerco la direzione)
Paziente: Voglio chiarire di cosa ho bisogno. Voglio smettere di vivere questo disagio… questa necessità… di stare da tutte le parti… di mettermi in mostra.
Terapeuta: Okay.
(Chiarito il significato che lei attribuisce ai messaggi ricevuti e quello che non le piace del suo comportamento, sarebbe possibile trattare il problema guidandola verso nuove alternative, magari assegnandole compiti specifici. Mi sento però spinto a maggiori approfondimenti, sono curioso di cosa alimenta la sua necessità di stare “da tutte le parti”).
(Parlo all’Adulto) Adesso sai come stanno le cose e come le vivi. Ti va di esplorare di più?
(Prima di imbarcarmi in un lavoro che richiederà un maggiore coinvolgimento emotivo ho bisogno della sua accettazione e del suo impegno. È un’attitudine contrattuale rivolta ad accertare se il paziente è disponibile e gli attribuisce responsabilità nel lavoro che propongo. Il mio intervento non è unilaterale. Mi dice di sì e allora la invito a sedere sulla sedia della bambina. Dopo un breve rilassamento le chiedo di andare indietro nel tempo attivando uno stato regressivo.)
Terapeuta: Sei una bambina piccola, nel tuo mondo, nel tuo ambiente. Fai qualcosa di molto simile a quello di cui hai parlato oggi, che sperimenti qui, nella tua vita attuale. Fai emergere immagini, scene…
Paziente: Sono nella mia casa… Ci sono tante cose in giro.
Terapeuta: Quanti anni hai? Come sei vestita?
Paziente: Ho quattro, cinque anni… Un vestitino a fiori, carino, mi piace… Ha una cinturina in vita…
Terapeuta: E che cosa stai facendo?
Paziente: Non so bene che faccio… Mi muovo per la stanza… Come se prendessi cose e le spostassi… Mi muovo veloce…
Terapeuta: Chi c’è con te?
Paziente: Mia madre. Anche lei sta facendo qualcosa, è assorta nei suoi pensieri. Va da una stanza all’altra e io la seguo
Terapeuta: E che cosa provi?
Paziente: Non lo so… sorrido… ma c’è qualcosa… non so… non sono contenta… non voglio star sola.
Terapeuta: Ti muovi su e giù, fai cose… Quali sono le ragioni per farlo?
(C’è un nesso con il comportamento di cui ha parlato oggi. Il suo essere dappertutto è un adattamento, ha una storia. Creo una continuità logica tra il passato e il presente. Gli schemi esistenziali attivi nel qui e ora ripetono vecchie organizzazioni emotivo-cognitive, e anche con le sostanziali differenze, dovute alla diversa maturità, la natura profonda dello schema conserva le stesse caratteristiche nucleari).
Paziente: Voglio essere vista, che c’è di male? Io ho bisogno di essere vista… Loro non mi vedono. (Lo dice con voce sommessa e incerta, da bambina).
Terapeuta: Come mai non ti vedono?
(Con le interrogazioni cerco di aprire il tema e di raccogliere dati).
Paziente: Succede quando non faccio la star.
Terapeuta: Sì, in qualche modo è vero, tu lo hai imparato e lo hai anche messo in atto… Fai la star, ma come mai per essere vista hai dovuto far così, cosa c’è dietro?
(Oltre al comportamento mi interessano le elaborazioni cognitive, i pensieri che la bambina ha costruito, perché questi determinarono il tipo di emozioni che imparò a utilizzare e le azioni conseguenti. Prende tempo, ritarda a rispondere).
Terapeuta: Come mai non ti vedono? (Ribadisco, Parlando ancora alla bambina).
Paziente: sono… cattivi… Non lo so… non mi vedono perché… non mi vogliono… stanno troppo nelle loro cose… ognuno ha le sue cose… (Lunga pausa, è assorta). E alla fine sto sempre sola… ( Ora piange).
(Sento questo pianto manipolatorio. Quali reazioni inconsciamente vuole attivare in me e qual è invece l’emozione naturale che reprime? A livello cognitivo sono emersi due elementi importanti: la convinzione ‘non sono voluta’ associata a una generalizzazione, ‘ognuno ha le sue cose’, che nella visione della bambina diventa ‘nessuno al mondo mi vede’. La convinzione si è formata su un nucleo cognitivo arcaico, idee e pensieri fissati nel tempo, sui quali ha sviluppato il proprio copione di vita. Dall’altro lato la generalizzazione paralizzante, che la lega a una visione delle cose per la quale tutto il mondo agisce con lei alla stessa maniera: nessuno la vede. Non c’è via di scampo, allora. Vive la sua esperienza come ineluttabile e sceglie determinati comportamenti che imparerà a considerare come gli unici possibili).
Terapeuta: A chi vorresti dire queste cose?
(Voglio tenerla in contatto con l’emozione che emerge, e allo stesso tempo farla uscire dalla generalizzazione, focalizzando la sua accusa su persone specifiche).
Paziente: Ai miei genitori.
Terapeuta: A tutti e due o a uno solo?
Paziente: Solo a mia madre.
Terapeuta: E’ lì, sull’altra sedia: focalizza la sua immagine. Che cosa vuoi dirle?
Paziente: Sei là, che stai facendo le tue cose, con i tuoi sogni… Ho bisogno che tu mi guardi e non mi guardi mai… Non ti importa niente di quello che sento, niente, niente, niente…
(Lo dice in un crescendo. Si conferma nella convinzione, ma ora protesta. Rinforzo la sua nuova attitudine).
Terapeuta: Pretendi che ti ascolti! Falle sapere ora, finalmente, quello che vuoi.
Paziente: Quello che sento… quello che voglio è che tu mi abbracci e che mi ami… (Di nuovo piange ed è un pianto più vero). E che mi stai vicina… non che mi schiacci… che mi opprimi… che mi stai vicina…
(Sta esprimendo bisogni che la bambina sentì insoddisfatti. Emerge l’immagine di una mamma distratta dalle proprie necessità o, quando si occupa della figlia, invasiva nel rapporto con lei. Mi chiedo quanto del modello materno la stessa paziente abbia incorporato. Ora però il mio obiettivo è di portare in primo piano i bisogni repressi e questo è facilitato dal contatto con l’emozione. La sta vivendo e ritengo utile che ne diventi anche consapevole. Cerco di creare nessi tra le esperienze che vive su diversi livelli: pensieri, bisogni, emozioni).
Terapeuta: Che cosa stai provando ora?
Paziente: Sono triste… e provo anche qualcosa… come rabbia…
(Sono sentimenti naturali adesso e la sento effettivamente coinvolta, eppure ancora si intravede una parte di lei che sta ‘facendo bene il compito’. Non mi sento partecipe alle sue emozioni. Non perché siano false, assolutamente. Eppure manca naturalezza, gli antichi adattamenti traspaiono. Il suo pianto non è pieno, ma leggermente lamentoso e la rabbia, pur visibile, è tenuta sotto controllo. Tuttavia sta affrontando un tema importante e quello che più conta per me, in questo momento, è favorire una chiara individuazione della sua organizzazione interna. Avere una mappa le servirà in futuro a focalizzare il lavoro personale su linee guida già tracciate. Le offro una struttura di riferimento).
Terapeuta: Quindi mamma o non ti vede o ti schiaccia e ti opprime.
(Così sintetizzo e riformulo).
Paziente: Uhm… si…
Terapeuta: E come fa a schiacciarti e a opprimerti?
(Ritengo utile che concretizzi in un comportamento definito quello che fa la madre. Che dia un nome alla sua azione. Finché resta nel vago non conosce il ‘ nemico’.)
Paziente: Mi abbraccia e mi dice… “poverina, poverina, poverina la mia bambina”. (E poi, alzando il tono) Io non voglio che mi abbracci così.
Terapeuta: È in questo modo che ti opprime?
Paziente: Sì… e mi da angoscia.
(Le chiedo di cambiare sedia e di identificarsi con la madre. È importante sentire le sue ragioni per potersene difendere. Ovviamente la madre rappresenta una incorporazione nella quale la paziente si identifica portandosela dentro. È un genitore interno, cioè è una parte di sì, quello che ora sta mettendo sulla sedia e vive come proiezione. Per un verso rappresenta la madre storica e per altro verso è il frutto di una elaborazione interna di quei messaggi e di quei modelli che realmente furono trasmessi alla figlia).
Terapeuta: E perché è una ‘poverina’ questa bambina?
Paziente: Sono mia madre? (Ha un attimo di titubanza prima di entrare nel nuovo ruolo).
Terapeuta: Sì. Diventa proprio lei. Le dici ‘poverina’ e poi l’abbracci, perchè?
Madre: Poverina… poverina, avrà una vita così dura… una vita così dura…
Terapeuta: Uhm… si? E perché?
(Non risponde alla mia domanda e continua, ossessiva).
Madre: Una vita così… una disgrazia.
Terapeuta: E come lo sai?
Madre: Io… la mia vita è stata una disgrazia…(Lo dice lamentosa e piagnucolando).
Terapeuta: Poverina… Se la mia vita è stata una disgrazia…(Controbatto un po’ ironicamente è un po’ provocatorio forzando il tono)… anche la tua …
Madre: (Interrompendo e piagnucolando ancora di più) Anche la tua sarà tutta una disgrazia.
(È una condanna che incombe sulla testa della figlia. L’identificazione simbiotica fa immaginare a L., che ora recita il ruolo della madre, che lei è portatrice dello stesso destino. Una pesante ingiunzione che le condiziona l’esistenza).
Terapeuta: Sì… Vuoi dire di più sulla tua disgrazia, mamma?
Madre: Sono sola, sono sempre stata sola…Anche io non ho nessuno che si sia interessato a me… Mi hanno lasciata sola… (Lo dice con rabbia sottile e colpevolizzante dietro il lamento).
Terapeuta: Sì…
Madre: (alla figlia) Io non ti lascerò mai sola come hanno lasciato me… mai, mai, mai…
Terapeuta: Ma questo non toglierà… (vengo interrotto)
Madre: Io sì che ho sofferto.
(Mamma prosegue imperterrita per la sua strada. Sta rivendicando. Vuole gratitudine e dipendenza. Manipola la figlia per tenerla stretta a sé. Sento profondo fastidio per questa immagine di madre che, con la sua apparente protezione, toglie alla figlia il diritto di vivere le sue esperienze dolorose, e proprio per questo la condanna a una sorda e non espressa sofferenza. Mi sento solidale con la bambina.)
Terapeuta: Sì, ma questo non toglie che anche lei soffrirà.
(È un implicito permesso che do a L.: esci dalla superficie ed entra un po’ più dentro, permettiti di vivere il dolore e la sofferenza dietro la maschera e l’immagine. Non consentire a tua madre di evitarti di essere umana. Per proteggere lei hai perso te. C’è una differenza tra la ‘condanna’ a che la propria vita sia ‘una disgrazia’ e il permettersi di vivere i naturali momenti di dolore. Adesso so quali sono le emozioni che ha represso a causa dell’ambiguità della madre).
Madre: Anche tu soffrirai… (Ripete meccanicamente e poi di nuovo manipola, impietosendo la figlia) Io ti voglio bene… Ci soffro…
(Invito la paziente a cambiare sedia e a riprendere il ruolo della bambina).
Terapeuta: (ora la provoco per stimolare una reazione) Vedi? Tua madre è generosa, non vuole che tu soffra… ti vuole bene e si prende lei tutta la sofferenza..
Paziente: (Urlando) No! Voglio soffrire, ho diritto a soffrire… Non tu… Smettila con il soffrire sempre tu, tu, tu, tu… Lasciami soffrire… anche a me.
Terapeuta: Ma come, ti ha detto che tu non hai il permesso di soffrire… (Incalzo) Lei ha il monopolio…
Paziente: No! Tu non sei l’unica che può soffrire… Che può sognare, che si può estraniare … E quando soffro mi fai sentire ancora peggio… (Piange) E non so che fare… non so che fare… Anch’io voglio soffrire. (Espira forte, alleviata. Si riappropria del diritto a sentire la sofferenza contrastando la pretesa della madre di vederla senza emozioni ).
Terapeuta: E dille per cosa soffri, qual è la tua reale sofferenza.
Paziente: Io soffro perchè tu mi mostri a tutti quanti… Perché tu mi obblighi a fare… a farti fare bella figura. Mi mostri a tutti come se io fossi un oggetto… “Guardate”… Soffro perchè mi pizzichi le guance così le ho più rosse… ‘E dai, sorridi adesso’. (Imitando la voce della madre) No, non voglio sorridere!
Terapeuta: Ti tratta come una bambolina?
Paziente: Sì, è così.
Terapeuta: E cosa le vuoi dire, ora?
Paziente: (Con forza) Non voglio essere per tutta la vita il tuo oggettino, non voglio più essere la tua ragione di orgoglio.
Terapeuta: Uhm.. Uhm.., ora si…
(Avendo affermato il suo diritto a soffrire, trova vigore per decidere di nuovo e apre la strada a nuove prospettive. Ma per dare significato alla sua decisione è necessario che conosca la scelta originaria dalla quale è partita).
Terapeuta: Sì, ora è così, ma prima, quando eri molto piccola, che cosa hai deciso di fronte a mamma?
(Creo un legame logico tra le decisioni antiche e le nuove alternative. Se vede chiaramente come si mise in trappola diventa più facile la possibilità di uscirne.).
Paziente: fai di me quello che vuoi… se così soffri di meno.
Terapeuta: Uhm…
Paziente: Se tu mi vuoi bene così… Faccio come vuoi tu, quello che vuoi tu (lo dice rassegnata).
È la decisione che le ha tolto il diritto di essere se stessa. Ha accettato di essere un’immagine, una bambolina che vive dei desideri dell’altro, che ha perso il suo senso di sé e per esistere si muove nel mondo cercando chi la vede. Per questo scopo spende la vita, sta perennemente in posa con l’eterno dubbio che forse, dietro la sua immagine, quella che la mamma esibiva, lei non c’è veramente, ‘non esiste’. E ancora oggi, che fisicamente vive lontano dalla madre, questa è di fatto lì, accanto a lei. Una presenza invisibile ma pregnante. Inesorabilmente le scandisce la vita secondo gli antichi modelli. Si esibisce per esistere. E’ molto importante per lei, altrimenti c’è il vuoto. Ricordo un’altra paziente lo stesso tipo di personalità. Mi disse che c’era stato un tempo della sua vita in cui camminava per strada con uno specchio in mano, letteralmente in mano, perché aveva bisogno ogni tanto di guardarsi, di vedersi lì riflessa E così si accertava di esserci.
L. aveva rinunciato alle sue emozioni e al suo mondo interno reprimendoli a favore dell’apparenza, della superficie, così come le aveva insegnato la madre, che a sua volta viveva dell’immagine della figlia. Ma quanto sforzo! E quante rinunce. Tutto questo per un poco d’amore. Uno pseudo amore che non la nutriva effettivamente, ma d’altro lato, le garantiva la sopravvivenza. Diventa allora dipendente dal modello che lei stessa ha elaborato e nel quale ancora oggi si identifica fino a perdere la cognizione che ‘esiste’ indipendentemente dalla forma di adattamento che ha costruito.
Terapeuta: Sarò la tua bambolina, se mi vorrai bene.
(Incalzo e amplifico la decisione per farle sentire la drammaticità dell’impegno preso).
Paziente: Sì… sarò la tua bambolina… Basta che tu mi voglia bene… sarò così tutta la vita. (Ora piange disperata) Ma non mi lasciare… (È proprio come la bambina di allora e confessa a se stessa quella a cui mai aveva dato voce. Si pulisce il moccio con il dorso della mano) Io non ti lascerò mai sola… come hanno fatto quelli lì con te…
(Ora vive il dolore antico per la rinuncia nata dalla paura di perdere la madre, la minaccia a causa della quale si costrinse a essere così come lei la voleva. È in uno stato regressivo ed emergono sentimenti naturali che vennero svalutati e poi dimenticati, sostituiti come furono dall’importanza attribuita all’immagine e al ‘movimento’ continuo che ne consegue, per essere vista. Oggi sopravvivono all’adattamento e la sua forma caratteriale, maschere vuote che mostra al mondo, senza che ne sussistano più le ragioni. Tira su con il naso come una bambinetta, con il volto chiazzato di rosso, non per i pizzichi della mamma che la vuole colorita, questa volta, ma per il pianto e i singhiozzi ).
Terapeuta: Che cosa provi adesso?
Paziente: Ora sento dolore… Ora capisco perché sono scappata così lontano… Ho sempre dovuto scappare per difendermi… E ancora mi tiene legata. (Singhiozza. Mi guarda, per la prima volta in maniera diretta, e sembra chiedermi aiuto. Le tocco leggermente le spalle massaggiandole. È un permesso a sentire la sofferenza, il dolore, contro il divieto ricevuto. E lei piange ancora di più. Sta imparando che ha il diritto di essere anche quando sta male. Le sto implicitamente comunicando che il mondo non è tutto uguale, ci sono persone che possono accoglierla anche quando non è ‘in mostra’ e non fa la star. La convinzione di non essere voluta è stato il nucleo cognitivo sul quale ha posto le basi per le successive decisioni limitanti, relative al essere una bambolina, al prendersi cura della madre, a non soffrire. Sono decisioni che improntano il suo ruolo in famiglia e le sue relazioni affettive.
Si aggiunsero nel tempo le decisioni relative all’inserimento sociale e lì, giocando sull’immagine, oggi vive da leader. Ma il divieto a esistere, paradossalmente, viene rinforzato proprio dagli insegnamenti materni, dati forse in buona fede, su come comportarsi: ‘mostrati, fatti vedere’. L’immagine che costruisce è la conseguenza del suo non essere, del suo voto d’identità. La maschera che di volta in volta assume, attenta come è allo sguardo dell’altro, anziché liberarla, paradossalmente, le conferma, ogni volta, che lei ‘non esiste’. È l’immagine che le dà vita. Ora può sentire il suo dolore. Lo considero un momento importante, perché dall’esteriorità sposta l’attenzione all’interno e il vuoto si riempie. Anche se soffre, nel dolore esiste. A partire dal contatto corporeo si attivano diversi livelli di esperienza. Si amplifica l’emozione, cambiano gli schemi cognitivi e le antiche convinzioni. Le cose non vanno sempre allo stesso modo. La mia azione terapeutica è guidata da ciò che sento: ora è simpatia e percepisco che lei si affida. Abbiamo una relazione).
Paziente: Legata con una corda… Un cordone ombelicale lungo lungo… che ancora non riesco a tagliare…
Terapeuta: E come succede praticamente?
Paziente: Ancora mi tiene imprigionata… Con le sue telefonate, dicendomi che sta male e facendo finta che sta bene. Se la chiamo mi dice: “ Ciao come stai?” E io dico “ bene e tu?”, “ molto bene, molto bene”, “ah si?”, “be… Ieri stavo morendo per un’intossicazione… però è passato… sto bene… molto bene… non ti preoccupare. E come stai tu?”. (Ha incominciato a recitare, imitando la voce e i toni della madre, da attrice consumata. Mi incanta con il suo teatro e mi infastidisce allo stesso tempo. Perde l’emozione e la contatta di nuovo dopo un po’).
Terapeuta: Cosa ti dice effettivamente?
Paziente: È come se dicesse “bene, bene… però sto morendo”… E allora non riesco a difendermi, a mettere distanza.
Terapeuta: Dille cosa ti aspetti ancora da lei.
(Per una sorta di paradosso non sciogliamo i nostri legami simbiotici perché illusoriamente ci aspettiamo ancora oggi di ricevere ciò che non avevamo da bambini, anche se tutto suggerisce che ormai è impossibile).
Paziente: Sto aspettando che non mi usi… Che non mi usi per ottenere apprezzamenti per te, per fare tu bella figura. Sto aspettando che mi guardi… (Piange) Che mi stai vicina, in silenzio. Che non mi mostri… che non mi spupazzi… non mi stringi come una cosa… e che non mi dici ‘poverina’… che non mi dici che sono bella… soltanto mi aspetto che mi stai vicina, in silenzio.
Terapeuta: Sarebbe un modo per dimostrarti che esisti? Che semplicemente ci sei?
Paziente: Sì.
Terapeuta: Diglielo… Mamma, stammi vicina in silenzio.
Paziente: Sì… Mamma, stammi vicina in silenzio, come quando stavi vicino alla porta della mia stanza, quando ti dicevo che avevo paura e tu ti mettevi su una seggiolina, a leggere. E io ti vedevo lì seduta e questo per me era il massimo… Perché non mi stavi addosso dicendomi cose e neanche stavi tanto lontana… Io vorrei che mi stessi più vicina, non tanto lontano, e vorrei anche che qualche volta non ci fossi. Che mi lasciassi libera… vorrei che tu mi stessi vicina senza pretendere che io sia in una maniera particolare .
(Parla con sincerità, accorata. Esprime il suo diritto a essere come è).
Terapeuta: Dillo a qualcuno nel gruppo ora.
(Socialmente si comporta come ha imparato a fare in virtù dei messaggi materni e le chiedo di prendere una nuova attitudine, dichiarando esplicitamente il diritto appena affermato. Un esperimento per rinforzarne la capacità di attuazione quando tornerà nel suo ambiente. Lavoro sul comportamento).
Paziente: (A una compagna di gruppo) Voglio che tu mi stia vicina senza pretendere che io sia in una maniera particolare.
Terapeuta: (Alla donna verso la quale si era diretta) Va bene per te? Puoi accettarlo?
Compagna di gruppo: Sì, mi sta bene così.
Terapeuta: A chi altro potresti dire la stessa cosa nella tua vita attuale, oltre che a mamma?
Paziente: A mio marito.
Terapeuta: Fallo.
Paziente: Voglio che tu mi stia vicino senza pretendere nulla di particolare… Senza aspettarti che io ti protegga…
Terapeuta: Anche mamma te lo ha chiesto.
Paziente: Sì, anche lei.
Terapeuta: Vuoi dire a tuo marito che vuoi smettere di vederlo un po’ come tua madre?
(Suggerisco frasi da ripetere che, quando vengono pronunciate direttamente dalla persona interessata, acquistano il sapore di una nuova possibilità, prima non inclusa nel proprio sistema di riferimento, e diventano acquisizioni personali. Si attivano nuovi processi cognitivi, e in questo caso, nuove prospettive relazionali).
Paziente: Non voglio più vederti come mia madre… E voglio che tu mi veda, anche se me ne sto in silenzio…
Terapeuta: E confessagli ora come glielo impedisci.
(Voglio che si renda conto che c’è una sua responsabilità anche nel comportamento del marito: è lei che glielo consente).
Paziente: Te lo impedisco stando attenta ai tuoi bisogni… proteggendoti e accudendoti come… E questa è proprio la stessa cosa… ( dichiara sorpresa).
(È la stessa cosa che ha fatto con la madre. Dapprima l’ho guidata nella individuazione del suo bisogno, invitandola poi ad amplificarlo. Lo condivide con il mondo, rappresentato in questo momento dal gruppo. Il gruppo lo accoglie e glielo autorizza. Ne diventa testimone. Ho poi allargato il tema dal rapporto con la madre alla sua vita attuale, con il marito, col quale ripete gli schemi infantili, per renderla consapevole della meccanicità del suo comportamento. Vivendo il paradosso della propria impotenza oggi, caduti i vecchi presupposti, può trovare delle alternative più adeguate e soddisfacenti).
Terapeuta: Bene, ora è giunto il momento di chiudere questa storia. Sei la bambina piccola e al tuo fianco c’è L. di oggi, seduta qui. Con le sue capacità, la sua comprensione della vita, ha tanta esperienza e può sostenerti.
(Attivo l’emozione della bambina e la consapevolezza dell’adulta insieme, per facilitare una presa di distanza dai vecchi legami e favorire una nuova decisione ).
Terapeuta: Dì a tua madre quello che non le hai mai detto e quello che vuoi dalla tua vita.
Paziente: Non mi importa se sono brutta… o se sono bella… voglio essere antipatica se mi va… e non m’importa nulla se mi ami o non mi ami… ma questo non è vero.
(A questo punto perde energia e avverto il rischio che possa ricadere nel ricatto dell’amore e quindi la incalzo, per rimetterla in contatto con la sua forza reattiva).
Terapeuta: Qui c’entra poco l’amore. È il momento di uscire dalla tua trappola, L. alzati in piedi, respira profondamente e continua a parlare stringendo i pugni… sì… che cosa le vuoi dire veramente?
Paziente: Non voglio più essere la tua bambolina… non voglio preoccuparmi di fare bella figura… non mi importa… ( Lo dice in maniera seria e vibrante. Poi sospira e si siede. È stanca).
Paziente: (Guardandomi e scuotendo il capo mi dice convinta) no, no… Basta fare la bambolina… questo usarmi… come una bambolina… non voglio farlo più. ( Si è affidata e guardandomi mi riconosce).
Terapeuta: E cosa vuoi fare allora?
Paziente: Se ho voglia di stare in un angolo me ne sto in un angolo. Non voglio fare la falsa simpatica… Non voglio.
Terapeuta: E cosa vuoi essere?
(Dal ‘fare’ passo all’ “essere”, la sua carenza di fondo. Da quanto racconta non ha problemi con l’essere attiva, mentre ha poco contatto con il proprio mondo interno.)
Paziente: Non so, cosa voglio essere? (Con tono innocente, spontanea)Non so… voglio essere come sono… (è ancora troppo vaga).
Terapeuta: Come, concretamente?
(È importante che l’intenzione abbia obiettivi concreti per poter essere realizzata).
Paziente: A volte timida, a volte con voglia di parlare… e non ho tanta voglia di mostrarmi. (Piange sommessamente e con un filo di voce) voglio davvero essere come sono… sincera, spontanea…
(Recupera il suo diritto di essere com’è, che per lei vuol dire diritto di esistere. Le lascio vivere per un po’ le emozioni perché le integri e poi utilizzo il momento di consapevolezza per consolidare le nuove decisioni in maniera cognitiva).
Terapeuta: Vai sulla sedia dell’Adulta ora, lascia tua madre e la bambina… mettiti con l’attitudine di una osservatrice esterna, neutrale. Che cosa ti ha colpito della tua esperienza?
Paziente: La cosa che mi ha colpito mentre lavoravo, e mi colpisce ancora, è questo fatto dell’oggetto… diventare un oggetto per mia madre… Ma ancora di più, non solo ero stata un oggetto per lei, mi spingeva diventare un oggetto per altri. Capisco ora il mio bisogno di applausi. Eppure c’era un tempo in cui ero timida e mi vergognavo, non volevo applausi.
Terapeuta: Uhm… Ora come Adulta che sa, che comprende le cose della vita, cosa proponi oggi, cosa suggerisci? Dì qualcosa a questa madre.
Paziente: Sì, questa bambina non può essere sempre forzata a fare come vuoi, non ce la fa, lasciala in pace.
(Creo un genitore ausiliare che parte dall’Adulto della paziente, cioè dalle sue stesse capacità di trovare alternative, rendendola responsabile nel darsi nuovi permessi. Per rendere più efficaci le prospettive di cambiamento appena individuate, proseguo utilizzando una tecnica attraverso la quale è la sua incorporazione materna che viene invitata a liberare la figlia dai messaggi limitanti che le ha inviato. È ovvio che le ingiunzioni materne sono oggi indipendenti dalla presenza effettiva della madre è che sono comunque frutto di un’elaborazione interna fatta dalla bambina. Ciononostante, poiché Di fatto sono attribuite alla madre reale, metaforicamente sarà proprio quest’ultima che potrà liberarla. In pratica è lo stesso potenziale della paziente che viene attivato attraverso l’immagine materna, per creare un riequilibrio all’interno della personalità. Parlo quindi alla paziente dopo averle chiesto di identificarsi nella madre).
Terapeuta: Oggi L. ti sta chiedendo di lasciarla in pace. È passato tanto tempo da quando lei era una bambina. Anche tu sei cambiata… Sei disposta a liberarla? Si sente ancora legata a te e pensa che hai bisogno di lei. Puoi liberarla?
Madre: Ora posso andare io davanti, qualche volta… Non devi andare sempre tu… Ti ho sempre mandato davanti da sola… nel buio.
Terapeuta: Diglielo più convinta, come fa una madre.
Madre: L., ora fai la tua vita, Vai libera… Puoi smettere di essere sempre in prima linea… Ora posso andare io davanti, da sola.
Terapeuta: E come vedi ora L.?
Paziente: Adesso è contenta. (Sorride)
Terapeuta: E tu, mamma? Cosa provi vedendola contenta?
Madre: (Incomincia a piangere intenerita) Vedo che sta bene… Sono contenta che stia bene.
Terapeuta: (alla madre) è passato del tempo ormai, e anche le tue ragioni sono cadute, puoi spiegare a L. il perchè dei tuoi comportamenti con lei?
(Voglio favorire il ristabilirsi di un contatto amoroso basato sulla comprensione e non più sul ricatto).
Madre: Senti… Tu avevi tanta energia… e tanta capacità di fare… e io sentivo molta paura… e tu andavi sempre avanti, aprivi la strada… tu aprivi la strada con tanta facilità… e io avevo paura.
Terapeuta: L. sta aspettando un importante permesso, solo tu glielo puoi dare, ne ha molto bisogno per dare un nuovo assetto alla sua vita. Vuole ascoltarlo dalla tua bocca, sei disposta a farlo?
Madre: Ho ancora un po’ di paura… Ma ti voglio bene… Sii te stessa, come senti di essere.
Terapeuta: E come, concretamente?
Madre: Prima di tutto puoi stare tranquilla… io ti voglio bene anche se mi vedi in un angolino, da sola, a pensare… E non preoccuparti… stai in contatto con quello che senti e fai la tua vita… non ti chiedo più dimostrarti, di lottare per essere vista… non sapevo che ti costava tanto. Mostrati come sei… timida o sfrontata, non importa… Stai in contatto con quello che senti… Non è il tuo compito quello che ti stai portando nella testa… non è il tuo compito.
Terapeuta: Torna sulla sedia dove c’è L., quella di oggi… cosa provi adesso?
Paziente: Mi sento bene… come uscita dalla gabbia. Mi sono scrollata di dosso una serie di divieti: questo no, questo no… Mi sembra di andare verso la libertà, ora ho delle possibilità.
Terapeuta: Sono contento. Mi piace la tua espressione… ti vedo viva. (Lei ride) E non hai l’obbligo dimostrare che ridi. (Tutti ridono) Ok. Io direi che quando un attore lascia la scena ha diritto al suo ultimo applauso. E sottolineo ‘ultimo’.
(Il gruppo applaude e lei ride contenta).